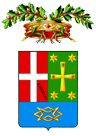L’autunno è alle porte e i primi freddi porteranno la chiusura delle feste popolari, quelle all’aperto che hanno deliziato migliaia di comensi da giugno fin qui.
Il bilancio numerico, a sentir gli organizzatori, non è del tutto negativo pur considerando l’estate trascorsa una delle peggiori del secolo. Ma oramai le feste e le sagre stanno in gran parte sotto i tendoni che rassicurano per le uscite e proteggono la serata.
Dunque. C’è qualche problema? Sì, se vediamo i costi, la concorrenza “sleale” e la qualità dell’offerta.
Cibarsi e divertirsi ad una sagra estiva è costato mediamente il 10percento in più (del 2013) e non è poco, ma nell’insieme familiare – con menu variabili per bambini e anziani – la spesa è stata ancora contenuta: meno che al ristorante o pizzeria, si dice.
La “concorrenza sleale” è un problema sollevato da Confesercenti a seguito di un indagine territoriale al fine di individuare quelle feste o sagre che non rispettano la regola principale: volontariato per scopi sociali o culturali. Insomma tutto il guadagno deve essere indirizzato al bene comune e non al vantaggio dei soci. L’abuso non è frequente, ma la regola va rispettata.
Infine la qualità: è il punto fondamentale dell’offerta provinciale che si presenta sempre più uniforme. Han perduto – feste e sagre – l’identità originale, le caratteristiche specifiche, le lavorazioni casalinghe che ne facevano il punto di riferimento per appassionati gastronomi. In quanto al vino, non è mai stato di gran qualità.
Se togliamo dall’elenco negativo quelle due o tre occasioni che la provincia di Como ha offerto ai comensi e ai turisti (non si nominano per non dover allungare di contro la lista nera) resta la banalità dei primi (lasagne, pasticci, orecchiette sorde, penne arrabbiate, trippe scialacquate… ma santocielo); secondi da lasciar senza respiro (mammamia le costine bruciate, le bistecche suolate, gli spiedini uguali di qui e di là - ma con nomi esotici differenti: “messicani, abruzzesi” alla “cilena”, persino). Per non parlar delle fritte patatine e dei dolci standard.
E la tradizione? E il piatto regionale siciliano, pugliese, tirolese, veneto e persino padano, lariano, lacustre, brianzoeu? Tutti persi nella fretta di scodellar numeri, di staccar scontrini, di accasar famiglie numerose e affamate.
Così non va. Se vogliam catturare qualche turista e accontentarlo e ritrovar qualche indigeno sarà il caso di ripensare il tutto: dal prodotto (anche locale) al modo di cucinarlo e presentarlo. Abbiamo migliorato l’organizzazione (poche file e pulizia discreta) ora tocca alle cucine. Il piacere della Tavola viene da lì.
Che la cultura alimentare sia oggi profondamente divisa, e le forze in campo siano in conflitto, non è una scoperta. Da un lato l’industria, dei semi come delle carni, e la grande distribuzione, con trasferimenti intercontinentali di derrate, dall’altro una mobilitazione variegata, con i piedi per terra e con tante etichette e tanti prefissi, eco- e bio. Associazioni quali il FAI, Greenpeace o Slowfood vi contribuiscono significativamente. Esiste una precisa linea di confine fra i due campi ? Solo su certi prodotti e su alcune filiere … Nella vita di ogni giorno, si fa la spesa, si riempie il carello e si leggono appena le etichette.
L’Expo fin dai suoi primi passi, due anni fa, ha deliberatamente ignorato questi conflitti, e per non attizzarli, ha evitato con cura di suscitare un dibattito su come bisognerà “nutrire il pianeta”. Niente orti per il futuro, niente padiglioni della ricerca scientifica, niente documenti che si prestassero a qualunque interpretazione. Una politica di sorrisi, verso Vandana Shiva, green glamour, e verso gli stati che rappresenteranno con il loro padiglione l’agroalimentare, una tattica destinata a far tacere domande e riflessioni, in una Milano, in un paese in cui la cultura alimentare non è solo consenso. Delle iniziative, trapelavano le più accattivanti, le più pittoriche : chi mai, eco- o bio-, avrebbe mai preso a calci il cesto di frutta del Caravaggio ?
Coloro che si occupavano di alimentazione, trovavano strano questo silenzio. Non presagiva nulla su un futuro trentennale che sarà caratterizzato da un aumento della popolazione, dovrà essere sorretto da una produzione agricola adeguata e metterà in gioco il ruolo competitivo degli allevamenti. Inoltre, come sperare di ospitare Slow Food e far tacere Carlo Petrini che da anni denuncia “i criminali” dell’agroalimentare ? La tattica non portava egualmente frutti nelle provincie limitrofe, e nelle regioni prossime in cui l’Expo figura come un polo con ricadute turistiche sostanziose. A chi si domanda, ancor oggi : che cosa sarà ? si risponde “una grandissima fiera”. Più di “Tuttofood” ? Molto, molto di più. Verranno milioni di cinesi …
Ed ecco che qualche giorno fa, qualcosa va storto. Negli ultimi dieci anni, se c’è una sigla capace di scatenare le guerre di religione, questa è OGM, organismi geneticamente modificati, semi prodotti e brevettati da Monsanto negli Stati Uniti, diffusi in Canada e “vietati”dall’Unione Europea. Dici OGM e scoppia un putiferio con scienziati che li difendono, con analisti a favore del seme e non del brevetto, con militanti che sbraitano, con la Coldiretti che media e finisce per schierarsi con gli anti. L’ipotesi che Monsanto trovi ospitalità nel padiglione americano dell’Expo, e lo finanzi, basta a scatenare la reazione. Conferenza stampa delle Associazioni, prime mobilitazioni, niente sit-in, in assenza di una Expo tutta in cantiere, ma presente con il suo marchio, su libri, arredi urbani, réclam. Al posto di una politica culturale, c’è il logo, anzi un monologo che, a distanza di un anno, è un déjà vu.
Visto dai laghi, non è misterioso il conflitto. Orti, supermercati, gas (gruppi di acquisto solidale) e, a Como, una agricoltura svizzera con i suoi zincarlin e i suoi merlot, e una formaggeria lecchese, bastano a concretizzare qui, come altrove, l’esistenza di modi diversi, compatibili e incompatibili, di produrre e consumare. E l’Expo ? Per fortuna, in piazza del duomo, non se ne vede il logo, logo del nulla, e gli scambi di delegazioni, o le visite di osservatori, non cambieranno le cose, tanto meno i problemi alimentari spicci o planetari. Non c’è niente di peggio che una cultura umiliata dal silenzio e dalla sola preoccupazione di portar a termine, senza denunce, il lavoro dei cantieri. Ma, per gli ottimisti, c’è ancora un anno per discuterne, ed a questo dovrebbe pensare proprio Lei, l’Expo, senza aspettare che le diatribe e i sit-in si attuino quando aprirà le porte.
Alberto Capatti
Nuovo cuoco milanese economico
Il ricettario apparve nel 1829 ed ebbe altre tre edizioni, l'ultima delle quali nel 1865. Si tratta di un ricettario ponderoso, un manuale in senso proprio, rivolto "ai cuochi, ai principianti e ai particolari". Nella prima parte si trattano gli argomenti di sfondo.... Nuovo cuoco milanese economico
Milano, Tipografia Motta, 1829.
1. L'autore
Su Giovan Felice Luraschi disponiamo di pochissime le informazioni. Le storie della cucina gli dedicano poche righe e nessuno storico si è mai curato di inseguirne le tracce negli archivi milanesi. Fu cuoco professionista e lavorò a lungo per alcune famiglie della buona borghesia cittadina. Non si ha notizia che tra le sue conoscenze ci fossero artisti, scienziati o politici. Si può supporre che nelle discipline umanistiche fosse un autodidatta. La sua scrittura ci fa certi che fu un uomo di varia, anche se non profonda cultura, ma che non ebbe, come altri cuochi, l'opportunità, di estendere i propri interessi oltre gli ambiti della cucina, del mercato e dell'economia domestica, poiché non risulta abbia operato in alberghi o in ristoranti alla moda.
2. L'opera
Il ricettario apparve nel 1829 ed ebbe altre tre edizioni, l'ultima delle quali nel 1865. Si tratta di un ricettario ponderoso, un manuale in senso proprio, rivolto "ai cuochi, ai principianti e ai particolari". Nella prima parte si trattano gli argomenti di sfondo: delle caratteristiche dei generi alimentari, degli utensili necessari nella cucina, delle norme di compilazione della lista delle vivande, della qualità e del taglio delle carni. Nella seconda parte sono esposte le ricette, ripartite in maniera professionale e non occasionale, rispetto al servizio dell'epoca. Ventisei ricchi capitoli, in cui si passano in rassegna tutti i tipi di entrées, di entremets (in italiano "trasmessi" o "intermezzi"), i diversi tipi di cottura, le verdure e gli ortaggi, le conserve e soprattutto i dolci, di cui il ricettario offre un regesto dei più ricchi tra quelli stampati in quegli anni.
Il Nuovo cuoco milanese difetta però di chiarezza d'esposizione, contraddicendo l'intento didascalico prefissato dall'autore. La terminologia è approssimativa e il linguaggio non uniforme, la sintassi incerta si disperde tra la lingua e il dialetto, come se il volume riunisse, con difetto di editing, materiali e appunti di diversa origine ad uso di cuochi già esperti delle tecniche e delle procedure. Un limite culturale che, forse, ha la sua radice nell'atteggiamento del Luraschi verso il proprio lavoro. Se è tra i primi a riconoscere l'importanza della comprensione organolettica degli alimenti ("il cuoco deve avere il palato buono, il gusto delicato per combinare esattamente i condimenti e le dosi"); non è però capace di comprendere se stesso e il proprio lavoro nella dimensione creativa, al di sopra della pratica del servizio: "...il cuoco deve inoltre essere sollecito nel lavorare per operare prontamente, e dee studiare con assiduità il gusto del proprio padrone, per cui il palato del cuoco dev'essere quello dello stesso padrone; una delle più belle prerogative che possa possedere, onde soddisfare il genio del medesimo".
3. La cucina del Nuovo cuoco milanese
Il Luraschi dichiara orgogliosamente che il suo ricettario è atto a servire "pranzi all'uso inglese, russo, francese e italiano". Il cuoco recepisce poco i mutamenti in atto nel panorama europeo. I "servizi", cioè la composizione dei pasti e le modalità con cui le pietanze raggiungevano i commensali si sono diversificati e a seconda delle epoche e dei territori. Nell'Europa rinascimentale si praticava il cosiddetto servizio "all'italiana", in cui le pietanze arrivavano tutte insieme sulla tavola, con la tavola stessa trasportata su paranchi. Dal XVIII secolo si preferì ricorrere al servizio "alla francese", scandito in tre tempi: prima i piatti caldi, dal potage fino agli arrosti, già sontuosamente sulla tavola al momento dell'arrivo dei commensali; quindi i piatti freddi e le verdure; infine la pasticceria. Negli anni successivi al Congresso di Vienna, quelli in cui viveva Luraschi, si impose il servizio "alla russa", più razionale e pratico, in cui i piatti caldi si servono individualmente in serie di dieci o dodici coperti alla volta: ed è questo il tipo di servizio usato ancora oggi. Contemporaneamente si cominciavano a gettare le basi per quella che diverrà, nell'arco di una cinquantina d'anni, la grande cucina internazionale. Luraschi non è in grado di fiutare la direzione del vento e, nella sua foga di apparire completo, si porta dietro il cascame del tempo passato: i servizi obsoleti e un repertorio di pietanze che non sanno decidersi tra il vecchio e il nuovo, tra le pompe del passato, le più modeste aspettative della borghesia milanese e le prospettive della cucina internazionale.
L'idea gastronomica espressa nel Nuovo cuoco milanese aderisce soprattutto alle indicazioni tecniche e di gusto della moda francese, quindi non si differenzia molto dalla letteratura culinaria coeva. Nella sua modestia e nella scarsa originalità complessive, il ricettario ha però un suo interesse nella sistematicità e, per chi abita il territorio prealpino, nel vasto campionario di ricette dell'uso milanese e lombardo, più ampio che negli altri Cuochi piemontesi e sedicenti milanesi: lo stufato, le zucchette, le broccole, la senape, la galantina di cappone (tutti piatti alla milanese) e poi la frittura di polenta, la zuppa di marasche, gli sbrafodeli, il riso con la coradella, il cappone non sono che esempi tra i piatti più conosciuti. Inoltre le specialità provenienti da altre città e regioni d'Italia, in via di affermazione nella Milano di inizio '800 (la zuppa alla romana, il fegato alla genovese e quello alla parmegiana, il manzo alla piemontese, la salsa anconitana, le alici alla napoletana ecc.) rappresentano un contributo all'idea di gastronomia del territorio italiano che proprio in quegli anni muoveva i primi passi.
Il cuoco ticinese ebbe tre edizioni, tra il 1849 e il 1879, con un discreto successo, che tuttavia non superò mai i confini del Canton Ticino. E' scritto in una prosa garbata e discreta, senza artifici retorici, attraverso una lingua modellata sul parlato .... Luigi Franconi
Il nuovo cuoco ticinese economico
Lugano presso fratelli Fioratti, 1846
Invia1. L'autore.
Non sono molte le informazioni degne di rilievo che ci sono giunte su Luigi Franconi. Nativo di Brissago, cresce apprende l'arte della cucina nella Milano della prima metà del XIX secolo e la perfeziona con "vent'anni di servizio in alcune delle migliori cucine di Milano ed adiacenze". La sua vita pubblica è tutta qui: nel servizio fedele, puntuale e guidato dal buon senso nelle cucine dell'alta borghesia lombarda, nelle quali, è noto, si mirava a far bella figura, ma si perseguiva allo stesso tempo una sana economia domestica, senza sperperi né fronzoli inutili.
Franconi pubblica il suo ricettario a Lugano, contribuendo a portare nella cultura alberghiera ticinese quella novità, rispetto ai criteri di sistemazione e di teorizzazione della tecnica e della pratica gastronomica avviati a Parigi da Antonin Carême con la sua monumentale Arte della cucina nel XIX secolo, quella novità degli intenti e del carattere, idealmente europei e cosmopoliti, che fu di incentivo all'aggiornamento e allo sviluppo delle infrastrutture turistiche ticinesi, così utili negli anni seguenti a promuovere l'economia della regione.
2. L'opera
Il cuoco ticinese ebbe tre edizioni, tra il 1849 e il 1879, con un discreto successo, che tuttavia non superò mai i confini del Canton Ticino. E' scritto in una prosa garbata e discreta, senza artifici retorici, attraverso una lingua modellata sul parlato (limite di cui l'autore è consapevole), che non disdegna di tanto in tanto il ricordo di qualche arcaismo o, all'opposto, forgia neologismi, semmai deformando il lessico francese. Lingua piana, ma non illetterata, in cui talvolta ricorre tra i termini francesi il ricalco delle forme del dialetto milanese, a riprova della genuinità pratica della cultura del suo autore, cresciuto e vissuto tra i fornelli e le pignatte. Si rivolge a un pubblico non troppo esigente (commercianti, impiegati, piccolo borghesi), e per questo non si prefigge la completezza e la sistematicità del ricettario del Luraschi; e non si distingue per originalità e fantasia; ma - al pari del Luraschi - non indica le dosi degli ingredienti, né qualifica in maniera puntuale le procedure e i tempi di cottura e di preparazione, quasi che si rivolgesse a cuochi professionisti già in possesso delle tecniche culinarie. E' in questa implicita sopravvalutazione delle capacità operative dei propri lettori, il limite maggiore del ricettario.
3. La cucina del Nuovo cuoco ticinese
La gastronomia ticinese, sia quella familiare che quella della ristorazione, risentiva, a metà Ottocento, i limiti di un ambiente chiuso in una dimensione popolare fondamentalmente autoreferenziale che esprimeva una cultura alberghiera ancora piuttosto provinciale. L'elaborazione culinaria ruotava principalmente attorno alle idee e alle pietanze di una tradizione popolare e valligiana semplice e modesta, non ancora toccata né dal lavoro di sistemazione e di codificazione attuato dai grandi maîtres francesi né dagli apporti che attraverso Vienna giungevano a Milano dalla Mitteleuropa e dall'Europa orientale. E d'altronde, anche Milano faticava non poco a trovare una sintesi tra i nuovi dettami d'Oltralpe e le necessità pratiche di una realtà in continuo cambiamento nella quale si andavano prospettando nuovi tempi e nuove forme per la produzione e dunque anche un diverso rapporto degli individui con le proprie risorse e con le proprie necessità, primo fra tutti il cibo.
All'insieme di queste suggestioni di cultura gastronomica si rifà Franconi, prospettando un modello che affonda le sue radici non tanto nella tradizione delle valli svizzere, quanto proprio nella cucineria milanese e lombarda. Da cuoco scaltrito, anche se non raffinatissimo, propone alimenti tendenzialmente semplici, una cucina schietta, di carattere popolare, riducendo, per quanto possibile, "i lambricati intingoli della cucina di Parigi, che più soddisfano alla moda che non al palato". "Col troppo raffinar i gusti temo che non abbiamo a guastarli". Franconi non si mette in concorrenza con i maestri del gusto d'Oltralpe, e appare orgoglioso di avere illustrato piatti italiani che, egli afferma, si cercherebbero invano in altri libri di cucina, ma che risultano servibili "tanto per cucina particolare come per albergo o trattoria". Se spesso ricorre alle "pome di terra", appena giunte dal Nord Europa, e all'acciuga usata come condimento tradizionale al posto del sale, alla stregua del garum di Apicio, mancano quasi del tutto, nella cucina del Franconi, le paste asciutte o farcite della tradizione italiana, come non sono recepite in pieno l'utilità e le potenzialità del pomodoro. Vi figura tuttavia - esempio raro nei ricettari dell'epoca - un "Pasticcio di polenta" con il ragù d'anguilla, che può essere assunto come opportuno esempio di cucina popolare lacustre.